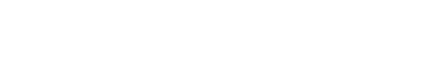Critiche artistiche
Critica di Renzo Castelli
tratta da "Bahariga" di Carlo Romiti (2003)
Carlo Romiti, il pittore dei cavalli
Il cavallo, che ha accompagnato fedelmente l'uomo nelle guerre e nel lavoro, umile o superbo, docile o bizzoso, non poteva non rappresentare materia d'ispirazione per artisti di ogni epoca. Se restiamo al campo della pittura, questo animale “sembra disceso dalle nuvole e inviato in terra dagli dei; la grande incollatura arcuata fa apparire nani i grooms, l'occhio fiammeggiante è pieno di disprezzo” (Thom Spencer, 1735). Abbiamo colto l'interpretazione di un artista in un'epoca nella quale il cavallo era idolatrato da nobili e plebei, un'epoca nella quale Ben Marshall raccontava: “Trovo più facilmente signori che mi pagano 50 ghinee per un ritratto al loro cavallo che non 10 per un ritratto alla loro moglie”. E questa preferenza fu davvero propizia poiché ci ha lasciato opere memorabili. Si può raccontare il cavallo ma lo si può anche amare e quando lo si ama è per la sua indole, non più per il suo aspetto. Così, nel cuore dell'artista, un cavallo normanno vale un arabo, un orlov vale un appaloosa. E' il caso di Carlo Romiti che, nel suo eremo nella campagna fra San Gimignano e Volterra, racconta i cavalli. Due ne possiede e gli altri sono tutti nella sua fantasia e sulla punta del suo pennello di artista raffinato. Cavallo come fine espressivo ma anche come mezzo poiché attraverso il cavallo, Romiti interpreta la natura che lo circonda. Sceneggiatore, scenografo, regista, docente di tecniche pittoriche, Carlo Romiti resta dunque soprattutto un pittore – un pittore di cavalli – come dicono le sue numerose mostre personali in Italia e all'estero e la partecipazione a collettive di prestigio.Renzo Castelli
Critica di Giuseppe Bonicoli
tratta da "Bahariga" di Carlo Romiti (2003)
Il mondo di Carlo Romiti
Conoscere Carlo Romiti e le sue opere, ma anche l'inverso, ha rappresentato per me una esperienza assolutamente straordinaria, di quelle che, nell'età cosiddetta matura, si fanno sempre più rare ed improbabili. Come mi è accaduto con tutte le principali passioni della mia vita mi sono incantato e sorpreso, emozionato e coinvolto. Per questo mi sono improvvisato (con tutta l'incoscienza che accompagna le passioni nuove) promotore dell'iniziativa che, grazie alla collaborazione dell'Alfea ed alla disponibilità di Renzo Castelli, ha consentito la realizzazione di questa mostra. Romiti dipinge terre, boschi, animali e soprattutto cavalli. Il suo rapporto con questo animale è di tale compenetrazione, quasi simbiotica, da trascinare chi contempla le sue opere in un percorso a ritroso nel tempo e nel significato dell'esistenza. Ogni rappresentazione è dominata dal rispetto, assoluto e indistinto, dell'animale e della sua natura e da un senso di libertà senza limite. Nei galoppi su terra rossa, nelle sinuose torsioni del collo, nell'esplosione dei muscoli, nelle brusche frenate, nell'improvviso spavento si colgono tutti gli innati ed originali caratteri del cavallo: la bellezza, l'eleganza, l'intelligenza, la potenza, ma anche la dolcezza dei grandi occhi e l'eterna paura. Sullo sfondo boschi e praterie apparentemente impalpabili ed indefinite, ma che si impongono rigogliose ed incontaminate. Quasi non c'è bisogno di vedere perchè si sente: la materia, la terra, i venti, le fitte boscaglie colme di profumi e misteri. Non vi è spazio per decorazioni, manipolazioni ed orpelli. Tutto si svolge nel mezzo e per mezzo delle sole e solenni decisioni della Natura. Si può anche percepire una ferma denuncia. Ma Romiti non ha bisogno di forzare la mano: quello che per noi può sembrare una magia per lui è semplicemente famiglia.Giuseppe Bonicoli
Critica di Riccardo Bruscagli
tratta da "Paladini di carta La cavalleria figurata" a cura di Giovanna Lazzi (2003)MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA RICCARDIANA

Le terre e i cavalli di Carlo Romiti
Carlo Romiti vive fra Gambassi e Certaldo, con sua moglie, due cavalli, e tre pastori maremmani. La macchia intorno alla casa, specie a primavera, è piena di caprioli e di cinghiali. Il suo studio è nell’antica stalla; rotoli di tela e di carta ingombrano la mangiatoia di pietra. Tutt’intorno, sugli scaffali, barattoli di vetro e mortai: gli arnesi primari del suo lavoro. Nei barattoli ci sono i suoi colori, o meglio le sue terre: terre vere, cercate su per le colline tra Firenze e Siena, grattate dal suolo e dagli anfratti dove il tempo inumano della geologia le ha lavorate e predisposte, in una gamma meravigliosa di sfumature. Marroni e bruni, certo; rossicci fiammanti; ma anche rosa di una delicatezza di cipria, e ocra e gialli di ogni immaginabile intensità. Conchiglie e madreperle, anche: nel mortaio che le riduce in polvere fanno un profumo di petrolio e di benzina, con stupore dei non intendenti e gran divertimento del pittore (“Con un po’ più di fortuna, diventavano il nostro oro nero…meglio di no”). I collanti con cui Romiti mescola le sue terre per stenderle sono l’uovo, l’acqua, più di rado l’olio di lino: affiorano ricordi di antiche letture, Cennino Cennini, Ghiberti, Vasari…Niente di primitivo, e niente di ingenuo, nel mondo naturale di Carlo Romiti. E niente di arcaico. Dietro la disarmante naturalezza delle sue scelte di artista, come dietro il garbo affabile del personaggio, non si fatica a riconoscere una sapienza consumata, una resistenza inflessibile, una serie di rifiuti tanto impliciti quanto elequenti, la volontà severa e tranquilla di chi si è tracciato un vocabolario mentale di gesti, di modi, di colori; e a quelli, a quelli soli, è pacatamente deciso a mantenersi fedele.
Di conseguenza, pochi soggetti, e pochi colori, nell’opera di Carlo Romiti. Animali: i prediletti cavalli, i cani, i cinghiali. Qualche rarissima incursione nell’umano; dalle pareti di casa scrutano l’osservatore pochi ritrattini ombrosi e inquieti, che inviterebbero (chi se lo sentisse) a pregarlo di insistere. Soprattutto, terre e marine: invase da un senso smisurato di spazio, in un delirio d’immensità. La gamma cromatica, ristretta alle terre, ai bianchi, al blu di Prussia, gioca su una tastiera di timbri e di variazioni di sorprendente emotività, spesso in suites da leggersi insieme, in serie, come un unico fascinoso spartito musicale. Carlo Romiti non parla mai di ascendenze, di suggestioni, di maestri: primo mitografo di se stesso, è il primo ad avvalorare la favola di una pittura che nasce dalla natura e dalla terra, quasi dall’attrito fisico con i materiali primari del suo lavoro. Ma non occorre un occhio particolarmente esercitato per riconoscere la qualità coltissima di questa pittura: per esempio, nell’imprimitura cromatica delle marine, una atmosferica eco turneriana.
Per la mostra che accompagna il convegno “Paladini di carta. Il modello cavalleresco fiorentino” Carlo Romiti si è docilmente quanto entusiasticamente piegato alle amichevoli richieste di una committenza inconsueta. Studiosi di letteratura cavalleresca e bibliotecari esperti di iconografia cortese gli hanno dettato soggetti, tipologia e misure dei suoi interventi, sin dall’inizio destinati ai due diversi ambienti della mostra: l’Aula Grande del Dipartimento di Italianistica e la sala balconata della Biblioteca Riccardiana. Romiti, d’altronde, ci ha messo del suo espandendo il suo intervento oltre la pittura, in una vera e propria istallazione d’arte, guidata e orchestrata da un talento drammatico e registico che riporta ad altri campi d’azione dell’artista, fervido metteur en scène e animatore di laboratori scenografici e teatrali. Di qui le sagome lignee dei due cavalieri che s’impennano grondanti di colore e di sangue sulla balaustra della sala Riccardiana; la testa equina di bronzo nel vestibolo della Biblioteca; il cavaliere smembrato nei pezzi lucenti del suo arnese, sospeso al matroneo dell’Aula Grade di Italianistica; o anche le sagome e le misure delle opere pittoriche su supporto di carta o di tela, ritagliate sulle caratteristiche architettoniche e d’uso degli spazi espositivi. In ambito di letteratura cavalleresca, non c’è molto da insegnare a Carlo Romiti. Nel suo studio, in mezzo ai barattoli e ai mortai, sono sparsamente assortite edizioni del Boiardo e dell’Ariosto, ma anche di altri titoli che si direbbero più specialistici; non a caso il contatto (ormai antico) fra Carlo Romiti e qualcuno degli organizzatori del convegno risale ad un fortuito incontro in libreria, dove Romiti insisteva a pretendere (qui sì, con qualche ingenuità) un’edizione acquistabile del Mambriano di Francesco Bello da Ferrara. E il suo studio era comunque affollato, anche prima di quersto convegno, di cavalli e cavalieri, spesso in acquerelli di dimensioni ridotte, con tanto di verso boiardesco o ariostesco come didascalia; e, anche, di ritratti di personaggi cavallereschi: anche Romiti, come Don Chisciotte e il suo curato, sembra essersi soffermato più d’una volta a immaginarsi come erano fatti gli eroi di storie così lungamente idoleggiate, e divenute così familiari. La pittura di soggetto cavalleresco di Carlo Romiti riporta al centro di questa imagery secolare un dato anche qui primario, preliminare: il rapporto, il sinolo, o piuttosto, nell’arte di Carlo, il corto circuito fra l’umano e il ferino, tra il cavaliere e l’animale. Del cavallo il Romiti, discendente di medici e veterinari, e appassionato cavalcatore lui stesso, discorre con la sciolta esattezza dello scienziato ‘naturale’; con una incantevole precisione di lessico, anche (da lui ho appreso, come nozione ovvia, cosa s’intende per un cavallo ‘rabicano’; peccato che nessun commento all’Innmorato lo registri, in nota al nome del celebre cavallo di Ranaldo, Rabicano appunto). Del cavallo, Romiti ha una percezione di straordinaria acutezza anatomica, fisica, ma anche mentale e spirituale. Il cavallo – lui dice – ha l’anima di un animale da preda; dentro, è un cervo, un cerbiatto, una creatura che sa di avere la sua salvezza solo nell’arma difensiva della corsa e della fuga. Dietro di sé, il cavallo sente sempre un’inseguitore; la sua forza di corridore è una forza spaventata.
Anche nelle opere di questa mostra, i cavalli di Romiti mantengono quest’indole atterrita, che si traduce in tensione spasmodica di movimento, e quasi in grida assordanti. Anche Bucefalo (o Buzifal, secondo il Boiardo), il feroce cavallo carnivoro di Alessandro Magno, nonostante il suo corno e la sua temibile fama, è visto da Romiti lanciato in una corsa pazza, le orecchie appiattite a sommo la testa, le froge enormi, dilatate, l’occhio perso all’indietro, quasi a misurare la distanza da un pericolo mortale (fig…..). E anche il palafreno della dama rosata (fig. ….) s’inarca nei due movimenti opposti e convergenti del collo e della zampa, disegnando un ovale di compressa energia, mentre la bella donna quasi sbanda all’indietro, squilibrata dall’irruenza della cavalcatura. Perché qui, in questa serie approntata per i “Paladini di carta”, il cavallo non galoppa più solo, come in tante opere precedenti di Romiti. Altrove, le sgroppature, le torsioni, le impennate, le raggruppate dell’animale sembravano recuparare, non foss’altro nell’inconfondibile uso dei colori di terra, sfregati e applicati, più che distesi, la dinamica ancestrale di reperti preistorici (le grotte dell’Alcantara?), stranamente ricombinata, però, con un segno anatomico sapientemente analitico, con un’allusività sfumata che ha fatto pensare a Leonardo. Ma qui il cavallo non è più la fiera in libertà. E’ il cavallo sellato, armato, guidato, educato dal cavaliere a divenire la sua altrà metà combattente, una protesi viva della sua virtù guerriera. Per la figurazione del cavaliere a cavallo, Romiti ha creato una serie di variazioni tra le quail è stato molto difficile scegliere quella ora esposta in Riccardiana (fig. ….); altre occasioni espositive, sperabilmente, restituiranno all’osservatore la completezza della serie. Ma il formato si ripete di opera in opera, di pannello in pannello: è un ‘piano americano’, col cavallo che s’impenna, scartando frontalmente, si direbbe, l’osservatore, mentre il cavaliere minaccia un fendente con la spada sguainata, sbilanciandosi dalla parte opposta, e venendo così a invadere il lato sinistro della pittura. Cavallo e cavaliere urlano all’unisono: l’animale in un nitrito altissimo, furente, il cavaliere in un grido di guerra che gli deforma la faccia in un nervoso ghirigoro. Le mosse del cavallo e del cavaliere, perfettamente coordinate, si dividono lo spazio, imprimendogli due diverse ma complementari direttrici di movimento: e tutt’e due sembrano ritrarsi per lasciare posto alla penetrazione diretta, aggressiva, della punta della spada, ineludibile fuoco emotivo della composizione. Il pensiero corre al San Giorgio di Cosmé Tura: stessa posa rispettiva del cavallo e del guerriero, simile elettricità di linee e di tracciato; perfino la stessa (involontaria?) briglia rossa che attraversa, come un nastro sanguigno, la partitura cromatica abbrunata della pittura.
Nell’Aula Grande di Italianistica, Carlo Romiti ha voluto giustapporre, in obbedienza al tema del convegno, due grandi composizioni: un “Notturno di Orlando e Agricane” e, sulla parete opposta, un gigantesco “Morgante e il granchio”. In questo modo, I due capolavori quattrocenteschi del romanzo cavalleresco italiano, l’Orlando innamorato e il Morgante, si trovano esemplarmente e debitamente affiancati, e il modello cavalleresco fiorentino paga il suo doveroso tributo alla Ferrara degli Este. Qui, niente cavalli. Orlando e Agricane parlano d’amore durante la pausa notturna del loro duello; e in quel parlement l’eroe cristiano trova modo di sancire solennemente la sua nuova natura amorosa: “Molte fiate son stato per onore/ e per la fede mia sopra alla sella;/ or sol per acquistar la bella dama/ faccio battaglia, e d’altro non ho brama” (I xviii 48, vv.5-8). Romiti affianca il profilo dei due eroi in primo piano, testa contro testa ed elmo contro elmo, anche se il Boiardo, più prudentemente, aveva collocato Orlando “presso alla fonte” e Agricane “al bosco più vicino”. Ma così, il testa a testa ideologico e sentimentale dei due cavalieri si fa icasticamente letterale, e altrettanto presente, sul loro duro profilo di guerrieri, si fa lo sfondo notturno della conversazione (“Guardava il conte il cielo e poi dicia: /- Questo che or vediamo, è un bel lavoro,/ che fece la divina monarchia; / e la luna de argento, e stele d’oro,/ e la luce del giorno,/ e il sol lucente,/ Dio tutto ha fatto per la umana gente”, I xviii 41, vv.3-8). La pia ispirazione di Orlando si sostanzia pittoricamente nello spettacolare blu della pittura, fantasticamente gremito di stelle: un abbandono favolistico raro nell’arte del Romiti, quasi un cedimento, di buon grado, alla suggestione notturna e leggendaria del testo letterario.
Alla suggestione romantica dell’Innamorato fa da contrapposto il grottesco Morgante pulciano, sulla parete di fronte. Il suo gigante appare, come ci si può aspettare da un così fedele lettore di cavalleria, obbediente all’originale: con le sue armi rimediate alla bell’e’meglio, il suo elmo di fortuna, il battaglio della campana come arma caratteristica. E’, per altro, un Morgante triste, stralunato, a un passo dall’essere morso dal granchio che ne causerà la morte: anche qui, la pittura sembra avere impeccabilmente intuito la singolarità sghemba e bizzarra del testo letterario; e, nel caso specifico, l’accidentalità antieroica, ridicolmente sproporzionata, della fine dell’eroe eponimo.
Si ripete spesso che l’artista, lungi dall’avere bisogno di libertà, necessita di patroni esigenti, di limiti, di richieste, di commissioni. Gli organizzatori del Convegno sono entrati in questo giuoco forse talvolta con troppa baldanza; questa è probabilmente l’occasione buona per scusarsene. Ma, onestamente, osservando i pezzi che Romiti ha allestito per la circostanza, si può convenire, credo, che si è trattato di una benefica baldanza. Le terre, I cavalli, le passioni cavalleresche di Carlo Romiti parevano attendere un’opportunità come questa per fare entrare in circuito tanta parte del suo mondo di artista e di intellettuale. Si può facilmente prevedere che, da questa particolare specie d’incanto, anche Carlo Romiti non si libererà tanto presto.
Critica di Mauro Civai
tratta da "Terre scelte", Siena (1995)
Armonie compiute
Accostarsi alla pittura di Carlo Romiti non è cosa agevole e, soprattutto, non è possibile farlo senza tener conto del personaggio, senza provare a capirlo fino in fondo e non entrandovi in piena sintonia. Perchè proprio di un personaggio stiamo parlando, cioè di una persona non comune che ostenta una vernice schiva e selvatica ma per poi rivelare, ad una più attenta disamina, un carattere intrigante e composito, una solidissima cultura, una tecnica tutta particolare. Direi che di più della tecnica merita parlare perchè il modo di fare pittura di Romiti è tutt'altro che semplice, benchè poi pervenga a risultati scarni ed essenziali nel solco della più alta tradizione toscana. Nelle sue tele, infatti, stende colori magri ed è avaro nel tracciare segni che di rado suggeriscono presenze riconoscibili. Ma le stesse tele, soltanto con la loro materica densità, avvertono di un cammino a ritroso, di un'introspezione che lascia intravedere interni scoscesi come voragini, fino a toccare profondità estreme anche in senso temporale. Non vi è pretesa di originalità o gusto di scoperta ad accostare le opere di Romiti ai segni graffiti cui i primitivi affisavano le loro elementari esigenze di comunicazione e rappresentazione, ma non è il risultato che qui interessa per quanto certamente apprezzabile per originalità e inventiva. Quello che preme puntualizzare è piuttosto il percorso attraverso cui si perviene a determinati risultati, che è un processo di levare, più affine alla fatica dello scultore. La quota più impegnativa del lavoro di Romiti consiste intanto nella preparazione del fondo trattato in modo che assuma un corpo autonomo fino quasi ad una tattilità tridimensionale e capace di vivere di luce propria. Su questa base, percorsa da vibrazioni da cui è impossibile non restare contagiati, Romiti opera un duplice processo di scavo. Il primo intervento è quindi fisico, per cui sulla superficie densa e rugosa vengono apposti graffiti tesi a suggerire, appunto un focus interpretativo. Ma lo scavo si inoltra poi per la via culturale pervenendo, per percorsi di secoli solcati con rapidità telematica, a rinnegare d'un balzo piani e piani stratificatinel tempo, fino ad una risultanza espressiva totalmente fisica, originaria. Uno specchio deformante, insomma, sul cui riflesso è improbo riconoscersi ma dove risulta d'obbligo avvertire un che di familiare che tanto più è coinvolgente quanto tende maggiormente a rimanere defilato e intoccabile. Attraversare le terre dove Carlo Romiti vive, vederle di notte mentre la luna le accarezza d'argento, aiuta a capire le ragioni del suo fare. Sono terre antiche, un nucleo ideale da cui si sono irradiate civiltà diversissime pur nella comune luminosità: la enese, la pisana, la fiorentina. E la presenza di questi civilissimi popoli ed ancora quella di coloro che nei secoli li hanno preceduti, persiste intatta e non solo come umbratile memoria. Da quei poggi terrosi, dalla macchia più fitta può sortire imprevviso un vecchio cinghiale o un' istrice irsuta. Ma quella stessa valle, posta tra San Gimignano, Volterra e Gambassi, può miracolosamente partorire anche un flauto etrusco che nelle mani di un vecchio contadino materializza una scena che pare rubata a una tomba di Tarquinia. Ecco quello che muove Romiti: non tanto la sapienza scientificamente strutturata dell'archeologo di professione, ma piuttosto la curiosità intellettuale di chi, come gli eruditi inglesi del secolo scorso, s'accosta a questa terra propenso alla meraviglia, aspettandosi un viaggio nel tempo ancor più che nello spazio. Una full immersion in uno sperduto pezzo d'Italia dove è più probabile rinvenire lacerti di un passato anche remotissimo rispetto agli assilli di un presente che qui non possono apparire se non fastidiosi e volgari. Cosa dire ancora. Forse merita accennare alla simbiosi di Carlo con questa terra: un rapporto coinvolgente fino all'intimità. Rintraccia da sé le terre con cui dipinge, cercandole con lo scrupolo ossessionato di un cercatore d'oro. Le rinchiude poi in piccoli vasi come alchemici tesori per poi strizzarle, mescolarle e maneggiarle secondo un rito che sa di allegra profanazione. Il suo lavoro, le sue mani, la sua testa, stanno quindi nella terra. Ma questa stessa terra sa essere generosa e si lascerà docilmente plasmare da chi riconosce e apprezza, perchè con essa si troca in compiuta armonia.Mauro Civai
Critica di Andrea Spini
tratta da "Terre scelte", Siena (1995)
Su Carlo
Gli elementi, i quattro: aria, terra, fuoco, acqua. Di che altro c'è bisogno? Sì, per speigare il cosmo e il nostro posto nel cosmo, a che altro rivolgersi, se non a ciò di cui siamo fatti? Ma come raccontarlo, quali i modi e gli strumenti quando sappiamo che ogni parola si apre sull'abisso del Grande Silenzio dal quale nessuna risposta ci è mai pervenuta? Ci avvolgiamo da sempre nella spirale senza fine della Parola, inanellando ghirlande sempre diverse e sempre uguali, perchè al fondo sentiamo altro, indicibile eppure presente, che preme senza mai disvelarsi, una presenza che tutte le diffrenze non riescono a nascondere nella sua perfetta identità con se stessa. Che fare, allora? Smemorarsi di lei, negarla nell'effimero delle costruzioni che nel tempo siamo venuti realizzando, disconoscerla o, al contrario, disporsi ad accettarla così come essa si dà, pronti a coglierla, grati, dove essa si manifesta, mai, comunque, nell'ordine del discorso? Ecco, allora, un sorriso, le orecchie dritte di una lepère in mezzo al granoturco, il vento nei rami di una quercia, gli occhi di un bambino, due mani che si stringono, e, all'opposto, e ancora, un ferro che squarcia la carne, il terrore sul volto di una donna, il ghigno osceno di chi comanda, diventare, tutte, Rivelazioni per chi sente che sotto i giochi della cultura umana, c'è la natura umana e che quest'ultima è la natura che non ha linguaggio diverso dagli elementi che la compongono, e che terra, aria, fuoco, acqua mai riposano, e che il loro perenne conflitto dà forma a ciò che noi diamo forma. Carlo è uno dei “felici pochi” che sa che non esistono colori mai visti, rumori mai uditi, forme di pietà mai esercitate, atrocità mai commesse: tutto è già dato e tutto è stato fatto. Solo che, ogni volta, per infinite volte, continuiamo (e continueremo a illuderci di “creare”, invece di riconoscere che si tratta, sempre e comunque, di un trovare o, meglio di un ritrovare, in un “infinito intrattenimento” dove mai nulla è uguale a se stesso pur restando identico. E' per questo che i blu, i rossi, i marroni bruciati, i rosa e i verdi, insieme ai neri che vanno a depositarsi su una tavola di legno, un vecchio “scurino” o una tela di Carlo, riescono a inquietarci: non sono i colori trovati in natura; così come le sempre più rare stilizzazioni di cavalli, cani, cinghiali non sono rappresentazioni del mondo animale; e gli uni e gli altri, al contrario, sono solo “figurazioni” e concrezioni di materia che immettono direttamente nel continuo farsi e disfarsi dell'ordito della natura, in quella presenza invisibile che si dà solo per squarci, in quel conflitto perenne che ci costituisce. Fatte di terre filtrate e impastate, le opere di Carlo nascono da mani che frugano il bosco e le cave, da occhi che interrogano l'arido e l'umido, dai sensi, non sono prodotti d'artigianato. La technè viene piegata, infatti, alle ragioni di una proposta artistica consapevole e autentica, per più aspetti unica, confitta e fondata come poche su una ragnatela di motivi etici e stilistici vissuti drammaticamente. Niente di più estraneo, dunque, alle opere di Carlo della nostalgia per “paradisi perduti” e “armonie celesti”; inutile cercarvi pacificazioni. La consapevolezza della scomparsa del limite – dolorosamente avvertita – diviene, infatti tensione lacerante fra la tentazione di esaltare la violenza primigenia della natura e l'opposta, di rimanere comunque fra gli uomini, anche se soltanto per mostrare impietosamente la perversione del loro ridicolo sogno d'onnipotenza. Così, anche se a volte le epifanie sembrano mostrare, con l'uso di tonalità calde e tenui, i barbagli di un fuoco benigno, un segno tracciato nell'aria, il volume freddo posto di fronte a masse oscure e agitate, ci riportano al cuore di tenebra che pulsa non più fidente sotto e dentro di noi. Le faglie non collimano più, slittano l'una sull'altra, frantumandosi: da Caos, Cosmos sembra essersi pericolosamente allontanato, fino a quando?Andrea Spini
Critica di Donata Bertoldi e Renzo Cresti
tratta da "Terre e marine", Livorno 1994
Lo stupore panico di Carlo Romiti
“In campagna studio, leggo, penso, scrivo /.../ lasciamo la città ai mercanti /.../ non sono della nostra razza” (Petrarca)Vivere la natura
Fin dal VII secolo a. C., epoca in cui, nella civiltà greca, si consolidano le strutture cittadine e si afferma un tipo di pensiero che abbandona progressivamente il mito, per approdare alla ragione, fin da questi tempi remoti si prospetta l'opposizione fra città e campagna, luoghi che divengono archetipi di posizioni differenti, posti su piani diversi, sia a livello di vita sociale, sia a livello linguistico e artistico. La città diventa un modello dinamico, s'identifica col progresso, ma il suo dinamismo è legato agli affari e il suo progresso è di tipo tecnico: in città non c'è (s)campo per la meditazione, per la riflessione interiore, la città è uno spazio senza spazio, né fisico, né spirituale, è un luogo chiuso, racchiuso entro confini precisi e pre-determinati, entro i quali il cielo è più piccolo e gli alberi vengono abbattuti per costruire le strade del “progresso”. In città, Romiti non potrebbe proprio viverci, non avrebbe spazio, sole, aria, terra, acqua, inoltre negli agglomerati urbani manca il senso del mistero e del sacro, che sprigiona invece dalla campagna, dove il silenzio – così importante nell'opera di Romiti – consente il raccoglimento, permette di prendere le distanze dal troppo, dal pieno, dai condizionamenti della moda e del mercato, che non consentono di rimanere genuini, mentre la genuinità, al di là dell'eterogeneità dei linguaggi e delle metodologie compositive, è oggi il vero a priori dell'arte contemporanea. E' difficile incontrare una persona, in questa nostra società telecratica, dominata dal denaro, che, come Carlo Romiti, sia totalmente e profondamente estranea al vivere in superficie dell'uomo televisivo. Come in Siddharta di Hesse, bisogna conoscere bene i mercati e i mercanti, prima di rifiutarli, altrimenti si compirebbero gesti ideologici, si farebbero critiche non basate sull'esperienza, correndo il rischio di un atteggiamento naif, cheporterebbe a una visione arcadica della cultura. Romiti ha una forte consapevolezza del vivere moderno, la sua pittura nulla concede a una visione en rose della natura, la quale di presenta nuda e diretta, vissuta veramente e quotidianamente, senza fronzoli, anzi con le durezze e le fatiche che il vivere la natura comporta. Niente è più estraneo alla pittura di Romiti della visione borghese e oleografica della natura, il suo è un pensiero arcaico per il quale è possibile dare del “tu” alla natura, identificandosi con essa: nella pittura di Romiti le immagini sono il pensiero. L'io-tu, uomo-natura, non è un rapporto ma un'unicità.Sapere intuitivo
Nelle culture primitive sono innumerevoli i racconti che ci narrano la superiorità morale degli animali sugli uomini; gli animali sono visti come portatori di un grande e profondo sapere intuitivo. L'uomo-Romiti si sforza di “imitare” gli animali, i suoi cavalli, che hanno costituito il filo conduttore della sua pittura fino ad oggi, sono chiamati a sé, per l'energia segreta che comunicano, Romiti cerca di far suo il sapere segreto dell'animale, il quale avvicina l'uomo alla natura e al destino. L'animale rappresenta l'ascendente mistico dell'uomo: la predilezione per il cavallo dice quanto Romiti sia attratto da questo aspetto arcaico, in quanto il cavallo fa parte della simbologia mistica, per la sua corsa in spazi aperti, per il suo essere lunare e solare a un tempo. Il cavallo, nella pittura di Romiti, fa da pendant al cane e al cinghiale, animali di terra, che congiungono gli elementi terrigni con quelli dell'aria. La pittura di Romiti sa regalarci uno stupore panico e lo stupore non è solo all'origine del pensiero, ma anche dell'emozione. Se lo stupore dà origine alla filosofia, vuol dire che sta prima e quindi è separato e separabile dai successivi ragionamenti. Il mondo dell'immaginazione è dunque una ragione pre-logica o a-logica (come quella dell'infanzia, altro tema caro a Romiti), dove il confine fra soggettivo e oggettivo è sfumato e le cose non sono state ancora imprigionate nella codificazione linguistica, ma i turbamenti della fantasia sono liberi, come quelli di un bambino. In tal senso la pittura di Romiti si avvicina ai caratteri della fiaba, del mito, della leggenda, affrontando una continua metamorfosi del reale nell'immaginario e viceversa. La pittura di Romiti si mostra nel suo essere così, come si mostra un albero: “gli alberi – scrive Hesse - “sono sempre stati per me i più persuasivi predicatori /.../ essi mirano con tutte le loro forze a un'unica cosa: realizzare la legge che in loro stessi è insita, costruire la propria forma, rappresentare se stessi”. Per ritrovare un senso al nostro esserci, Romiti tende a “ricostruire memorie per un futuro che forse” - come scrive Andrea Spini - “è già nello stupore di fronte ai segni nei quali ci troviamo immersi da sempre”.Forma naturale
Romiti sa dar corpo a una forma naturale, a una plasticità del tratto che si fa viatico intelleggibile dell'espressività, una forma che non possiede simmetrie ed equilibri studiati a tavolino, ma possiede molto di più, perchè è nata da uno stato di necessità e forse non è solo l'espressione del singolo, ma vi si può intravedere anche il volto della Grande Madre, l'essere tale e quale è, l'essere che ha luogo, che nel suo divenire diventa ciò che è. I segni di questa forma non creano rapporti in cui un elemento si relaziona a un altro ma sono gesti che realizzano il, proprio aver luogo, il loro essere così: il quale in quanto è il tale. Questo scoprire le radici di ogni aver luogo, crea un'allusività capace di trasportarci dalla cultura all'innocenza, in quanto ogni grande artista è un po' bambino e come ogni bimbo ha la facoltà di possedere le cose. La natura è stata per Romiti soprattutto terra e animali, ora è anche acqua: questi elementi non sono materiali grezzi, come nell'arte materica degli anni Sessanta, piuttosto sono un atto d'amore, esprimono il furor del gusto creativo, rappresentano silenziosamente i luoghi da cui quegli animali e quelle terre provengono, colori trovati e impastati con pazienza e rispetto, come fosse (ma forse lo è) un gesto sacro, una ricerca delle radici più profonde dell'uomo. Romiti è la sua natura: i suoi colori esprimono gli umori delle stagioni, gli odori della terra, il colore e la temperatura dell'acqua, una temperatura emotiva, rivelata dal suo gesto veloce, sicuro e istintivo, plasticissimo, che sembra “avanzare ipotesi di una nuova configurazione del racconto, tale da assumere le sembianze di mito nell'età contemporanea” (come ha scritto Giandomenico Semeraro).Ecologia interiore
Una nuova configurazione mitologica, una vicinanza al senso del Fatum si esprime con fede nell'opera di Romiti e in questo viaggio verso il cuore della natura, Romiti non può non scoprire il mare, elemento considerato originario da quasi tutte le culture. E' un mare che confina con la terra, quasi circondato, dalla terra:“sporgendo d'un balzo fra le rocce
/.../ agitavi
le tue braccia d'avorio”
(Marinetti)
Il segno si fa volume e i volumi creano delle forme naturali; il gesto nasce dentro la tela, con animo puro, sgombro da preuccupazioni intellettualistiche: sono le mani ad essere intelligenti e a esprimere con la loro sapienza l'ecologia interiore.
Le terre, il mortaio, lo straccio, la mano
La terra riempie la tela, è forma e spazio, è volume corposo. L'immagine che si forma non è paesaggio, non c'è descrizione, non è questo che vuole Romiti; la forma è implicita, tutt'uno con le cose di cui è fatta; i colori si dispongono sulla superficie, creano percorsi, forme, superfici e volumi. Agli occhi di chi guarda l'immagine si crea lentamente, appare e scompare: prima si colgono le sensazioni forti degli impasti cromatici, poi le superfici si animano di profondità, di chiaroscuri, particolari prima sfuggiti emergono e si impongono. E' la superficie a parlare raccontando l'eterna vicenda che solo la superficie di una pietra, di un tronco, della terra percors ada mille venature sa raccontare. Ma non è un racconto è un esserci, un mostrarsi, con tutta l'arcana potenza della natura che è, comunque. La terra non è raccontata o descritta, la terra “è” il quadro fisicamente. Come lo era per gli antichi maestri, un po' artigiani e un po' alchimisti, intenti a macinare pazientemente nei mortai di pietra frammenti di lapislazzuli, terre, gusci, einnumerevoli altri materiali tratti spesso dal quotidiano più ovvio e che solo l'occhio trasparente dell'artista sa interpretare. Così Romiti va alla ricerca delle “sue” terre, quelle del volterrano e del senese. Come ogni artista che è un bambino e “vede” ciò che per l'adulto non ha più significato, scopre la vena perticolare, coglie quella manciata di terra che gli darà una sfumatura inedita, le trita finemente, la miscela, l'allunga, la stende con tecniche diverse. La terra non rimane inerte materiale, ma acquista nuovo senso dal rapporto con l'uomo: la mano, lo straccio, il pennello lasciano segni diversi, storie diverse. Romiti “entra” letteralmente nel quadro anche quando la tela non viene stesa sul pavimento, asseconda la natura, interviene con sapienza. Vive in Romiti il legame antico del toscano con la sua terra, un rapporto di reciproco amore dove la natura svela inedite bellezze, dove la cultura diventa natura.Donata Bertoldi e Renzo Cresti
Critica di Giandomenico Semeraro
tratta da "Intra nos animalia" di Carlo Romiti (1993)
La voce della terra diventa ossessione per un artista, lo segue per tutta la vita attirandolo sempre più entro di sè. E’ il suo sordo brontolio ad attirarlo, i suoi ritmi spezzati, lenti, adagiati sui millenni, fragorosi nell’urto e nell’urlo di un secondo: allo scorrere delle stagioni si accompagna il dialogo fra vita e morte nel quale si indovina il senso profondo della vita. E’ la lama sottile della tauromachia, il rischio che l’uomo porta sempre piu in là - quando lotta ad armi pari –, sfiorando la morte, e facendo di questo arte: una faena, e il toro passa vicino; un pase de pecho, e il toro sfiora il petto, poi scivola via. L’artista è solo di fronte ai passaggi che vorrà seguire, sta a lui la scelta, l’istinto a seguire un rumore, un suono, camaleonte, ormai, che assorbe i colori ed i gradi, la temperatura dei territori che percorre, bevendo, di questi, la linfa. E’ un’esigenza fisica, ma che, nella consapevolezza dell’arte, richiede orientamento mentale e la volontà di mantenere la direzione che gli consentono di individuare la sua tensione in sintonia con la tensione del presente. Ed in questo c’è qualcosa di ineffabile, perfetto e pruriginoso: il gusto della mano a seguire passo passo le indicazioni progettuali che mutano col farsi stesso della ricerca, che crescono col divenire dell’opera. Opera che si scrolla di dosso le ammirazioni univoche di un percorso che pare obbligato quando, invece, è assolutamente impossihile determinarne gli sviluppi creativi. Rimane la voce della terra, ossessione, verifica puntuale, campo di lavoro, scuola severa dalla quale le arti visive non si possono allontanare, pena una grave perdita di senso, ovvero latitanza linguistica, quindi comunicativa. La pittura è per Carlo Romiti terreno di questa impresa, suolo vergine già dalla tela bianca sul quale poter costruire il racconto visivo: costruire ~ indicazione corretta, il pittore fa, letteralmente, la pagina, tira su le forme, stende bagliori di luce che ne cementino il corpo. Così la scelta delle terre come materia pittorica risolve un’esplorazione di Romiti alla ricerca dei bagliori più cupi nel bosco, ovvero la luce più spietata: incontro improvviso col blu di Prussia, con le terre di Siena lungo spedizioni di raccolta di materiali per l’arte, dei quali l’arte si nutre. Appartato, l’artista assorbe il mondo che gli sta intorno; Carlo Romiti scompare alla civiltà per entrare in una civiltà dei colori e dei suoni nella quale l’uomo è animale, e l’animale diventa pianta, macchia, ripa scoscesa, natura memorabile chc conosce il Giudizio Universale. La linea si confonde con la luce, è un’immagine appena intravista che si lega alle altre fino a formare un mosaico complesso del quale la pratica pittorica è la chiave di volta; la linea è da intendersi come elemento costitutivo della realtà, come spinta concreta - più che segno di confine - che interviene individuando per il colore una direzione significativa, capace di recuperare ad un’altra soglia di consapevolezza la propria natura. Romiti esploratore della forma si addentra in un magma che riconosce come suo e nel quale si riversa la propria coscienza di artista; l’atmosfera si carica di umore, diviene elettrica al contatto della mano, acquista senso man mano che se ne individuano gli odori terragni. Il segno accarezza il collo, racconta il rumore di un torso ruvido che si sfrega sulla corteccia ruvida di un albero, le pieghe che si accavallano per un prurito insopportabile; il segno, ancora, rivela la velocità del galoppo, il corpo dell’animale gia trascorso ed impresso per un attimo di fronte agli occhi, immediatamente riassorbito dal bosco e dalla materia. La materia che è vita e prevede nel proprio ciclo anche la morte: i mastini sui cavalli, i cinghiali sui cani, barriere roboanti di pochi secondi dei quali viene dilatata la presenza fino all’infinito, il tempo che assume in Cronos le proprie sembianze piu terribili. Il segno si arrotola con gusto sul nero di vite, si compiace sulle ocre scartando la ripetizione conoscitiva ed ingigantendosi umoralmente fino ad avanzare ipotesi di una nuova configurazione del racconto, tale da assumere le sembianze di mito nell’età contemporanea, considerando quindi la pittura come il luogo per assumere forza dalla realtà. Le froge del cavallo fremono di piacere, impazienti per la corsa che sta per partire; Romiti ne sente il palpito vivo sulla vitalità della materia, il gusto bruciante per la mano che percorre il cammino dell’uomo fino ad oggi tendendo un ponte con le proprie origini ancora incandescenti, come una ferita mai rimarginata, e delle quali, allo scadere del secondo millennio, è necessaria la consapevolezza.
Giandomenico Semeraro